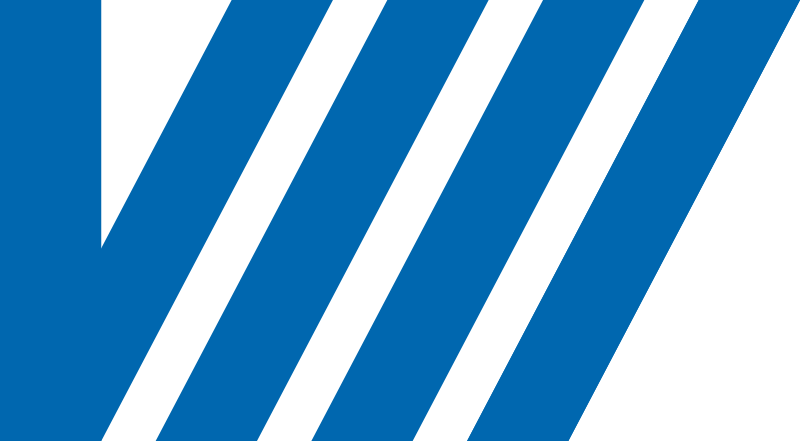
IL PROGETTO
Il Molo ottavo del Porto di Trieste prevede la realizzazione di un terminal container polifunzionale di ultima generazione, integrato con le infrastrutture pubbliche circostanti, per potenziare la capacità e l’efficienza del Porto di Trieste.
L’obiettivo è aumentare capacità e competitività per gestire la domanda crescente di trasporto merci, rafforzare l’intermodalità e generare valore economico, occupazionale e ambientale per il territorio. Il progetto risponde infatti alla saturazione operativa del Porto, ormai diventato uno snodo logistico europeo strategico grazie ai suoi fondali e all’intermodalità ferroviaria.
L’opera consiste in tre ambiti di intervento principali: opere a mare, opere a terra, attrezzature portuali e automazione.

Infrastrutture a terra
Il terminal prevede la costruzione di una nuova piattaforma ferroviaria interna al terminal con sei binari da 300 metri, progettati con lo standard europeo UIC 750m e predisposti per l’estensione fino a questa lunghezza in futuro.
Questo sistema è pensato per trasferire una quota significativa di merci dalla strada alla ferrovia e quindi portare a un significativo abbattimento delle emissioni di CO2, in linea con i parametri europei.
La capacità ferroviaria attesa a regime è di 12 treni al giorno.
Inoltre, è prevista la realizzazione di un piazzale dedicato allo stoccaggio e alla movimentazione di container e semirimorchi, dotato di attrezzature all’avanguardia e tecnologie di ultima generazione pensate per garantire operazioni sostenibili ed efficienti. In particolare, ci saranno 3 gru RMG elettriche a controllo remoto, dotate di tecnologie avanzate a basso impatto acustico e luminoso.
Vi sarà l’identificazione automatizzata tramite sistema OCR (optical character recognition) e varchi automatizzati con controllo accessi RFID e videosorveglianza.
Sono previsti due accessi separati al terminal per i mezzi pesanti e per i veicoli di servizio.
Infrastrutture a mare
Il terminal prevede la realizzazione di una banchina lunga 422 metri con fondali di esercizio a -17,2 metri. Questa configurazione è in grado di accogliere navi portacontainer di grandi dimensioni, fino a 15.000 TEU, ed è predisposta per futuri adeguamenti per navi ancora più grandi, fino a 24.000 TEU.
Per raggiungere la profondità di -17,2 metri sono previste opere di dragaggio e opere idrauliche. I materiali del dragaggio verranno conferiti per circa il 95% nella cassa di colmata sotto l’impalcato dell’adiacente piattaforma logistica.
Le acque meteoriche verranno drenate attraverso opere lineari di collettamento e trattamento con apposite vasche e/o cuscini filtranti.
La banchina sarà dotata di bitte ad alta resistenza e parabordi ad alta energia di assorbimento e sarà predisposta con cavidotti per l’integrazione futura di un sistema di Cold Ironing (alimentazione elettrica delle navi da terra).
Inoltre, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo accosto dedicato alle navi RoRo (Roll-on/roll-off), ovvero navi progettate per il trasporto di veicoli su ruote, come auto, camion, o vagoni ferroviari sulle quali i veicoli possono essere caricati e scaricati “rotolando” su rampe, senza bisogno di gru o altri sistemi di sollevamento. L’accosto avrà una lunghezza di 232 metri per navi di moderna generazione e prevede bitte da 150 ton e parabordi cilindrici.
Attrezzature portuali e automazione
Il Terminal intermodale Molo ottavo prevede l’installazione di attrezzature portuali moderne ed elettriche, come gru di banchina (STS), gru di ferrovia (RMG) e gru di piazzale (RTG) completamente elettriche. Queste attrezzature incorporeranno tecnologie avanzate per massimizzare sicurezza, efficienza e sostenibilità, con sistemi a controllo remoto, automazione parziale, efficienza energetica, recupero di energia elettrica e soluzioni per limitare emissioni acustiche e luminose (es. soft landing, illuminazione a LED). Le gru saranno alimentate a 10 kV e dotate di sistemi e azionamenti moderni per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi, inclusi dispositivi per il recupero dell’energia elettrica.
Inoltre, verrà implementato un sistema TOS (Terminal Operating System) per la gestione integrata delle operazioni (tracking, pianificazione treni, ecc.), sistemi di controllo accessi digitali (OCR, RFID) e un elevato grado di automazione per garantire fluidità operativa e sicurezza.

Vista sul Porto Nuovo di Trieste (Molo VII, Molo VIII e terminal petrolio SIOT) da Muggia

Scorcio con inquadratura sul Molo VIII
La rigenerazione dell’area ex Ferriera di Servola
Il Molo ottavo sorgerà in un’area bonificata dell’ex Ferriera Servola, oggetto di un più vasto e integrato piano per la riqualificazione e lo sviluppo dell’area, il cui obiettivo principale è convertire l’area della ex Ferriera, fortemente inquinata da oltre un secolo di attività siderurgica, in un moderno e sostenibile polo logistico.

Infatti, il Piano Regolatore Portuale (PRP) individua l’area ex Ferriera di Servola come prioritaria per lo sviluppo di attività container e Ro-Ro e beneficia di finanziamenti pubblici e privati, essendo riconosciuto tra i Progetti di Interesse Comune (TEN-T) a livello europeo.
- La trasformazione dell’area di Servola prevede:
- la Messa in Sicurezza Permanente (MISP), approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy con Decreto N. 39 del 30/01/2024,
- la realizzazione della nuova stazione commerciale di Servola;
- la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento del Molo ottavo con la Grande Viabilità Triestina (GVT);
- Edifici Pubblici per l’agenzia delle dogane e la guardia di finanza e un museo dell’Archeologia Industriale.
La MISP prevede:
- il confinamento dei terreni e dei materiali contaminati da idrocarburi pesanti, metalli e gli altri elementi derivanti dall‘ attività siderurgica mediante la realizzazione di barriere idrauliche a monte e a valle dei volumi contaminati e un capping superficiale, costituito da una membrana plastica e calcestruzzo e che restituirà oltre 150 ettari di terreno rigenerato alla collettività;
- il riutilizzo in loco, in condizioni di completa sicurezza, dei rifiuti recuperati. Cessata la condizione di rifiuto, questi vengono distesi, compattati e incorporati all’interno della MISP, al di sotto della membrana impermeabile, dove restano completamente isolati. In questo modo si realizza la base strutturale a terra del nuovo Terminal, riducendo l’impatto ambientale e la possibilità di estendere la contaminazione al di fuori dell’area in cui è stata generata, si evita lo smaltimento del rifiuto e il ricorso all’approvvigionamento di materiali dall’esterno del sito.
- l’attivazione di un sistema di monitoraggio ambientale e manutenzione a lungo termine necessario a garantire l’integrità e la funzionalità dell’opera. Grazie al completamento della messa in sicurezza prevista entro il 2026, saranno restituiti alla collettività oltre 150 ettari di suolo bonificato e pronto per nuove attività economiche.
Il progetto relativo alla nuova stazione di Servola prevede invece la realizzazione di un nodo intermodale a dieci binari adatto a convogli lunghi fino a 750 metri, progettato per gestire treni merci interoperabili secondo standard europei ERTMS. Il progetto ha completato l’iter di approvazione previsto dalla normativa in materia di opere di interesse strategico; i successivi passaggi verso la sua realizzazione comprendono la conferma e la ricezione dei finanziamenti e, successivamente, l’affidamento degli appalti. Questa è un’opera fondamentale per gestire l’elevata quota di traffico ferroviario prevista (fino al 65%) e sono sviluppate anche sull’asset di RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Infine, la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento del Molo ottavo con la Grande Viabilità Triestina (GVT) sarà una nuova strada che aiuterà a separare il traffico pesante da quello urbano, portando benefici alla circolazione cittadina con rampe dedicate per separare i flussi pesanti da quelli urbani, riducendo l’impatto del traffico su Servola e sulle aree residenziali. Anche questo è un progetto che deve ancora essere approvato, ma che permetterebbe al Terminal Molo ottavo di funzionare al massimo delle sue potenzialità.
L’intervento contribuisce alla rigenerazione urbana, riqualificando un’area senza nuovo consumo di suolo e migliorando la qualità ambientale locale (aria, acqua, suolo) in sinergia con la rigenerazione in corso. La fase di costruzione è prevista tra il 2027 e il 2030.
Per quanto l’integrazione di queste infrastrutture con il nuovo Molo VIII consentirà un flusso logistico tra porto, ferrovia e rete stradale, eliminando strozzature e riducendo al minimo le interferenze con il tessuto urbano, tuttavia, la funzionalità del Terminal intermodale è indipendente dalla realizzazione della nuova Stazione Servola e il nuovo collegamento del Molo ottavo con la Grande Viabilità Triestina.
Benefici dell’opera
Il progetto Molo ottavo rappresenta un investimento infrastrutturale strategico per il Porto di Trieste, con effetti diretti su entrate fiscali, attrattività economica e posizionamento competitivo nei mercati internazionali e con un impatto significativo in termini occupazionali, sanitari e di riqualificazione urbana, con benefici diffusi sia a livello cittadino che regionale.
Lavoro, sicurezza e ritorno economico per la comunità
Il progetto creerà lavoro stabile, qualificato e accessibile, sia nella gestione diretta del terminal che lungo le filiere logistiche, industriali e di servizio collegate, e un ritorno fiscale per il sistema pubblico.
Gli impatti occupazionali, risultano rilevanti già nel breve periodo: durante la fase realizzativa si stimano circa 805 ULA (Unità Lavorative Annue). Nel lungo termine, con l’entrata in esercizio delle opere, si prevede la creazione di circa 2.650 nuovi posti di lavoro — tra occupazione diretta, indiretta e indotta — in relazione al volume di TEU movimentati e all’aumento delle efficienze di scala.
Secondo le stime del Centro GREEN dell’Università Bocconi (2023), il progetto contribuirà alla generazione di un gettito fiscale aggiuntivo di oltre 2 miliardi di euro nei primi 15 anni.
Una maggiore sicurezza lavorativa è inoltre garantita dalle tecnologie introdotte dal progetto, che permettono una separazione fisica maggiore tra gli operatori e le aree a rischio. Le rendite arriveranno principalmente da: IVA all’importazione, dazi doganali, IRPEF da nuova occupazione (diretta e indiretta) e tasse portuali e di ancoraggio. Di questi importi, una quota significativa resterà sul territorio regionale, anche grazie alla quota di compartecipazione IRPEF riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il terminal sarà in grado di gestire fino a 0,4 milioni di TEU/anno nella prima fase, con possibilità di espansione futura fino a 1,6 milioni di TEU/anno. La configurazione è studiata per garantire un’elevata quota di traffico ferroviario (fino al 65%) e una piena compatibilità con gli standard europei.
Questi valori non saranno raggiungibili senza l’opera. A conferma delle mancate opportunità economico-finanziare derivanti dalla mancata realizzazione dell’opera, è anche la Delibera con Raccomandazioni del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile – GU 30.12.2024).
Un porto sostenibile, integrato nel contesto urbano
Il progetto avrà benefici ambientali diretti grazie ad una riduzione significativa delle emissioni climalteranti, con scelte progettuali orientate all’efficienza energetica e all’elettrificazione, e alla limitazione dell’inquinamento luminoso e acustico, grazie all’adozione di tecnologie per l’illuminazione intelligente e la predisposizione per l’alimentazione elettrica delle navi in banchina.
Salute pubblica e bonifica ambientale
L’area interessata è adiacente ad un’area interamente classificata come zona produttiva dismessa adesso in recupero ambientale. Infatti, l’intervento si colloca nell’area ex-Ferriera di Servola, dismessa nel 2020, precedentemente sede di un impianto siderurgico ad alto impatto ambientale. Si inserisce quindi all’interno di un più ampio piano di rigenerazione urbana, senza consumare ulteriore suolo, migliorando qualità dell’aria e delle acque.
Miglioramento della competitività e della capacità del sistema logistico del Porto di Trieste
Il terminal sarà in grado di gestire fino a 0,4 milioni di TEU/anno. Rendere il porto di Trieste più veloce, più affidabile e più competitivo per rispondere a una domanda crescente di servizi portuali efficienti e intermodali è condizione essenziale per attrarre nuovi investimenti e consolidare le connessioni logistiche strategiche del territorio. Il terminal intermodale faciliterà l’inoltro rapido delle merci su ferrovia, con l’obiettivo di trasferire una quota crescente di traffico dalla strada alla rotaia, contribuendo così alla riduzione delle esternalità negative del trasporto stradale.
Riduzione dei tempi di viaggio
L’intervento garantisce tempi di transito certi, costi competitivi e qualità del servizio affidabile per i trasportatori, riducendo le inefficienze che oggi limitano il potenziale del sistema. La riduzione dei tempi di viaggio comporterà una riduzione del consumo di carburante, comportando risparmi economici per le compagnie logistiche e marittime di oltre 0,5 miliardi di euro in 15 anni. Questi vantaggi incidono direttamente sia sulla competitività del Porto di Trieste rispetto ad altri hub europei, sia sull’impatto ambientale positivo dell’opera, concorrendo a ridurre le emissioni. In tal modo, il progetto consente il consolidamento del ruolo del porto rispetto alla concorrenza del Northern Range, offrendo una soluzione logistico-marittima più vicina e intermodale per i traffici Far East–Europa centrale e garantendo vantaggi in termini di distanze, tempi e costi di trasporto per l’hinterland europeo.
Sostenibilità e impatto ambientale
Il progetto Molo ottavo del Porto di Trieste è stato concepito per integrare le più avanzate soluzioni in termini di sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, il principio DNSH (“Do No Significant Harm”) e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) richiesti per l’accesso a fondi pubblici:
- intermodalità ferroviaria e riduzione delle emissioni. La configurazione operativa del terminal prevede che almeno il 65% dei flussi in ingresso e uscita siano gestiti via ferrovia, riducendo il ricorso al trasporto stradale. Tale configurazione consente un abbattimento significativo delle emissioni climalteranti;
- elettrificazione delle attrezzature e riduzione emissioni locali. Tutte le principali attrezzature previste sono alimentate elettricamente;
- cold ironing (alimentazione nave da terra). Il terminal sarà predisposto con cavidotti per l’integrazione futura per cold ironing lungo la banchina, una soluzione che consente l’alimentazione elettrica delle navi durante la sosta in banchina;
- gestione delle acque e infrastruttura sostenibile. Tutte le superfici operative saranno appositamente realizzate per consentire la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche verso specifici impianti dedicati al trattamento e alla depurazione. Gli impianti di trattamento dell’intero terminal avranno l’obiettivo di depurare le acque meteoriche prima del loro scarico e saranno dotati di vani di disoleazione per intercettare e trattenere eventuali oli e idrocarburi leggeri;
- inserimento paesaggistico. L’infrastruttura si sviluppa all’interno di un contesto industriale preesistente, senza nuova edificazione in ambiti naturalistici o agricoli.
Aspetti ambientali in fase di cantiere
La maggior parte delle criticità ambientali del progetto sono concentrate nella fase di cantiere, prevista tra il 2027 e il 2030. Questa fase avrà degli impatti temporanei che includono:
- incremento del traffico pesante e quindi delle emissioni e del rilascio di polveri dovute ai lavori;
- rumore e vibrazioni localizzate, soprattutto di giorno;
- dilavamento dell’area di cantiere con possibile spostamento di materiali durante le piogge più intense;
- movimento dei sedimenti di fondale durante le operazioni in mare, come il dragaggio e l’infissione dei pali per la costruzione del molo;
Al fine di ridurre gli impatti, soprattutto in fase di cantierizzazione, saranno adottate le seguenti misure:
- Studi e Controlli: Prima, durante e dopo i lavori ci saranno studi ambientali approfonditi e un piano di monitoraggio per controllare costantemente la qualità dell’aria, dell’acqua, il rumore e altri aspetti.
- Gestione del Cantiere: Verranno adottate misure per ridurre le polveri (per esempio bagnando le aree) e per controllare l’acqua che scende dal cantiere. Si cercherà di riutilizzare materiali e di riciclare almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi prodotti durante i lavori.
- Riuso e Trasporti: Si promuoverà il riutilizzo di materiali all’interno del progetto stesso e l’uso di mezzi di trasporto più sostenibili per i materiali necessari.
In sintesi, il progetto comporterà degli impatti durante la costruzione, ma temporanei e gestiti con misure specifiche. Nella fase operativa, grazie anche a tecnologie moderne come il “cold ironing” (se verrà realizzato) e a una gestione attenta delle risorse, si prevede un netto miglioramento ambientale rispetto alla situazione preesistente dell’area ex-industriale.

Confronto della vista su Servola da Muggia – con Ferriera di Servola

Confronto della vista su Servola da Muggia – con Molo VIII
Aspetti ambientali in fase operativa
Una volta completato, con il terminal in funzione, cambieranno gli impatti ambientali.
Rispetto a quando c’era l’industria pesante, la situazione ambientale generale nell’area migliorerà notevolmente soprattutto per quanto riguarda l’acqua, l’aria e il suolo.
Emissioni inquinanti ed emissioni sonore
Il progetto del Molo VIII è stato sviluppato secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ambientale, in linea con il Green Deal europeo, il principio DNSH (Do not significant harm) e i Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Il terminal contribuirà in modo significativo alla riduzione delle emissioni climalteranti nel periodo 2023-2072, grazie a una logistica intermodale che prevede la gestione ferroviaria di almeno il 65% dei flussi merci.
Inoltre, la posizione di Trieste consentirà una riduzione media di circa 2000 miglia nautiche rispetto ai porti del Northern Range, portando a un risparmio stimato di 8,15 milioni di tonnellate di CO₂eq, pari a 1,3 miliardi di euro (valore 2023).
Le emissioni inquinanti legate ai trasporti arriveranno dalle navi in banchina, dai camion che portano e prendono merci e dai mezzi che operano nel terminal e ammonteranno a circa 688 mila euro.
Le emissioni sonore dal traffico di mezzi (stradali e ferroviari), dalle navi e dalle operazioni di carico/scarico in ambito urbano sono stimate in 8,5 milioni di euro. Il progetto rappresenta un passo concreto verso la decarbonizzazione del settore portuale.
Acqua
Il terminale è progettato per una gestione sostenibile delle acque meteoriche, proteggendo l’ambiente circostante. Le superfici operative, compresa la banchina, raccoglieranno le acque di dilavamento per indirizzarle a impianti di trattamento. Questi impianti depureranno le acque di prima pioggia, rimuovendo solidi e particelle inquinanti. Saranno presenti anche sistemi di disoleazione per trattenere oli e idrocarburi, così come previsto dalle normative ambientali vigenti.
A regime, sarà attivo un sistema di monitoraggio continuo per ambiente e flussi, e verifiche sulla gestione acque e MISP. Il progetto include predisposizioni per futuri upgrade elettrici, come il cold ironing, a carico dell’Autorità portuale.
Paesaggio
L’aspetto della costa cambierà con la presenza del nuovo molo, delle gru e delle aree container. Tuttavia, l’impatto visivo e morfologico non sarà significativo per la percezione dalla città di Trieste stessa e anzi dovrebbe migliorare rispetto a quando era attiva la ferreria.
La particolare conformazione del territorio, l’andamento della costa e lo sviluppo degli edifici tendono a nascondere l’area del Molo ottavo dalla vista di gran parte della città. Mentre si potrà notare a tratti la trasformazione spostandosi lungo la strada statale SS 202.
L’infrastruttura si inserisce in un’area industriale esistente, senza impatti su zone naturali o agricole. È progettata per integrarsi armoniosamente nel paesaggio, con tecnologie per ridurre rumore e inquinamento luminoso. Sono previste schermature paesaggistiche e l’ottenimento dell’autorizzazione regionale. L’opera si integra bene nel contesto urbano e portuale di Trieste. Rappresenta una transizione significativa verso un modello industriale sostenibile e moderno.
Crisi climatica e resilienza
La progettazione tiene conto della resilienza dell’infrastruttura ai futuri cambiamenti climatici (come l’aumento del livello del mare o eventi meteo estremi). La scelta tecnologica per il terminal (ASC) contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra rispetto ad altre opzioni.
